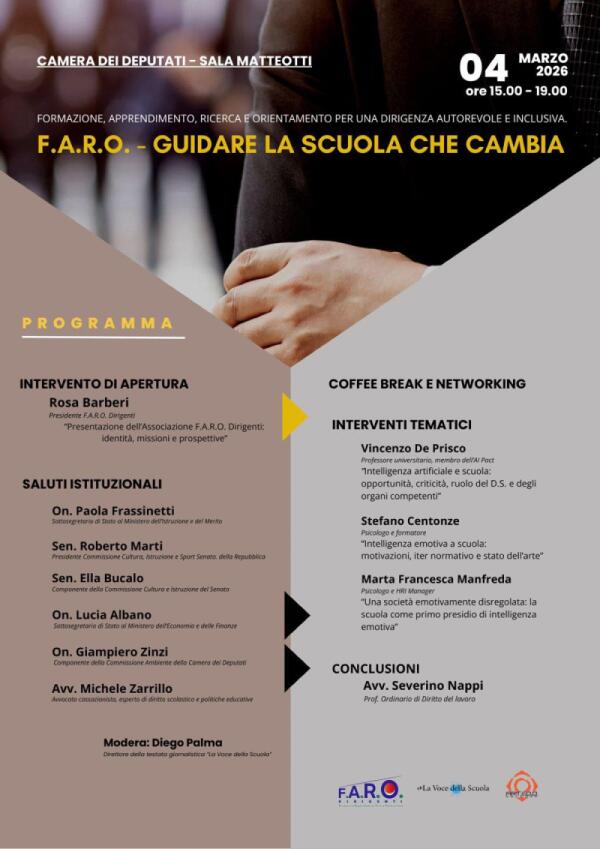Camilleri, Pasolini, e la lite interrotta
Il confronto tra i due, quindi, prende una rapida piega sulla cattiva tradizione attoriale italiana, per il teatro, della recitazione enfatica e irreale della poesia.
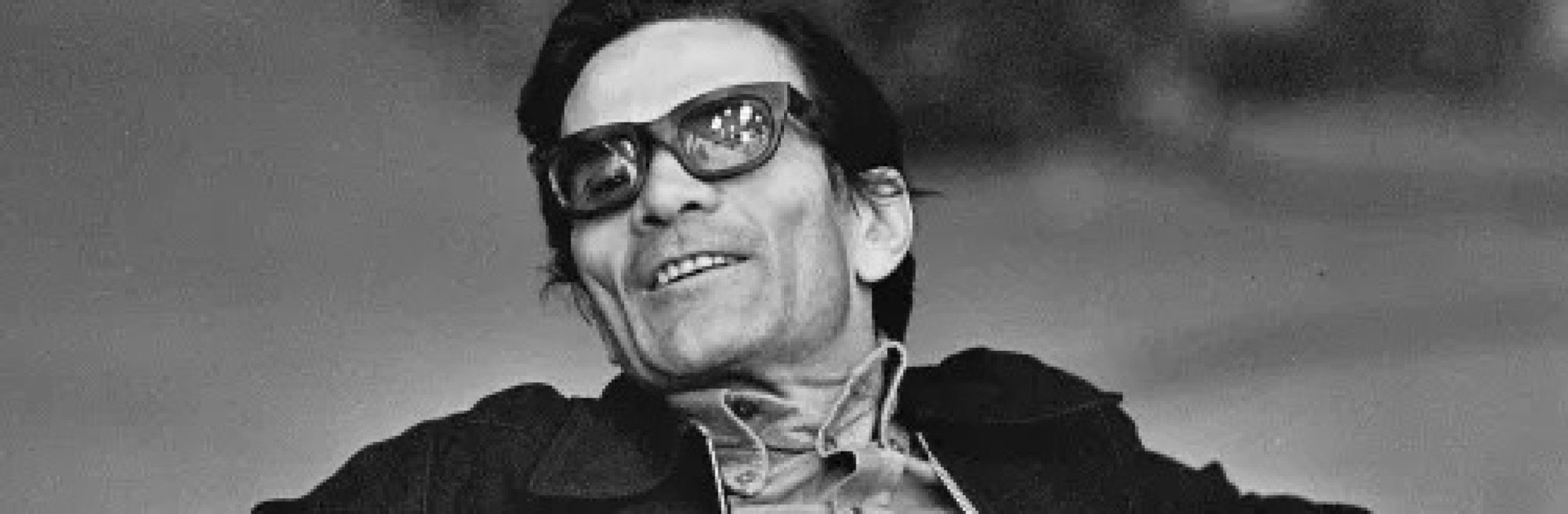
di Trifone Gargano
Nel libro scritto a quattro mani con Tullio De Mauro, La lingua batte dove il dente duole, Editori Laterza (Roma-Bari 2013), in forma di conversazione, Andrea Camilleri regista di teatro ricorda, con malinconico rispetto, di una lite con Pier Paolo Pasolini, avvenuta nel 1975, poco prima che Pasolini venisse assassinato, intorno alle questioni attoriali, e all’ipotesi di una messa in scena, da parte sua, della tragedia Pilade di Pier Paolo Pasolini, scritta nel tra il 1966 e il 1967, e stampata sulla rivista «Nuovi Argomenti», in due puntate (luglio e dicembre 1967).
Nel libro, Tullio De Mauro, nella sezione intitolata «Ad alta voce», riflettendo sulla necessità (e utilità) di leggere e far leggere (specie in sede scolastica) le poesie a voce alta:
Credo che non si debba mai dimenticare che anche il suono della lingua è importante. L’onda della parola si apprezza solo leggendo ad alta voce.
Aggiungendo, comunque, con il suo solito guizzo ironico, che gli era capitato di ascoltare anche «pessime letture». Camilleri conferma questa idea di De Mauro, distinguendo tra lettura d’autore e lettura di un interprete, ricordando che Ungaretti, in modo straordinario, quando leggeva le sue stesse poesie, in realtà «ruggiva, non leggeva, non diceva, ruggiva…».
Il confronto tra i due, quindi, prende una rapida piega sulla cattiva tradizione attoriale italiana, per il teatro, della recitazione enfatica e irreale della poesia. Occorre che adesso io riporta, qui, lunghi passi dei due interventi:
DE MAURO Su un vecchio numero del «Borghese», che Laura Betti ritrovò nell’Archivio Pasolini, Gianna Preda [pseudonimo di Maria Giovanna Pazzagli, 1921-1981, giornalista e sceneggiatrice, gran polemista, collocata a destra, che con Pasolini, suo compagno di liceo a Bologna, ebbe sempre un rapporto di odio-amore; fu redattrice capo de «Il Borghese» di Leo Longanesi, e nel 1963 collaborò con Pasolini per il film La rabbia, curandone la sceneggiatura, diretto, per la prima parte, da Pasolini, e, per la seconda parte, da Giovannino Guareschi] racconta una serata che rischiò di essere tempestosa. Era il 1971 o 1972. Gassman aveva avuto una buona idea. In uno scantinato di via dell’Oca aveva organizzato uno spazio in cui discutere i problemi della recitazione nel teatro italiano. Una sera ci andai anch’io. C’erano anche Pasolini e Laura Betti, e ovviamente Gianna Preda.
Cercai di spiegare a Gassman che ci stavamo avvicinando al possesso collettivo dell’italiano, e che per via delle nostre varie provenienze era difficile trovare una buona recitazione […].
La realtà de dialetto, in cui abiti e che ti abita, era ancora molto viva, mentre l’italiano era vissuto come un’imposizione, con pessimi risultati quando si trattava di palcoscenico. Gassman mi ascoltava, accettava e non accettava quello che dicevo. L’esempio più calzante che mi venne in mente – e lo feci, ma ovviamente senza fare nomi perché proprio non potevo – era il caso di attori che avevano recitato splendidamente in film comici, come lui (ma non lo dissi) nel film I soliti ignoti, ma che quando avevano a che fare con Shakespeare o Dante recitavano ai limiti dell’intollerabile, perché sentivano di dover salire di livello. Gassman mi interruppe. Capì che stavo parlando di lui e disse: «Professore, se lei continua, le rompo questa bottiglia in testa».
Nell’intervento di risposta, Camilleri, giustificando Gassman, per la formazione ricevuta in Accademia, che lo portava a recitare le poesie in modo enfatico, da “fine dicitore”, ricorda un suo episodio, collocabile nel 1975, di incontro / scontro con Pier Paolo Pasolini, proprio sulla questione del realismo nella recitazione, e della scelta degli attori dalla strada:
CAMILLERI Mi viene in mente che fu proprio per questo motivo che mi lasciai male con Pasolini. Quando mi diedero l’incarico di mettere in scena il suo Pilade, ci incontrammo da Laura Betti. Lui mi disse, contrariato, che come al solito avrei scelto degli Attori dell’Accademia, alla Gassman. Gli risposi che gli attori dell’Accademia non erano tutti come Gassman. Lui tagliò corto e mi disse di prendere gli attori dalla strada, i primi che incontravo. «Senti – dico – questo è teatro, non è cinema, non è che gli puoi mettere un microfono sotto e poi… È teatro, se questi non danno una buona emissione di respiro, non sanno le regole elementari, la voce non arriva. Quello che tu hai scritto non arriva, quindi è come se non l’avessi scritto. Che ragionamento è, ci vogliono attori esercitati, ancor più per Pilade». «Va beh, domani parto, ne riparliamo quando ritorno». E invece l’ammazzarono, e io non me la sentii di mettere in scena Pilade visto che non avevamo risolto questo dissidio. Mi sarebbe piaciuto poterne riparlare con lui. Fargli capire che l’attore di teatro, quando è bravo, è un’altra cosa.
Pilade di Pier Paolo Pasolini fu accolta in modo molto freddo dalla critica. Andò in scena, per la prima volta, al Teatro antico di Taormina nell’agosto del 1969, con la regia di Giovanni Cutrufelli, con la Compagnia Siciliana del Teatro. Solo nel 1981, con la regia di Melo Freni, andò nuovamente in scena, a Benevento, presso il Teatro Romano, con alcune variazioni introdotte nella messa in scena da parte del regista (come, per esempio, l’idea di coinvolgere nell’azione scenica del pubblico). Infine, nel 1993, Luca Ronconi la riporta in scena a Torino.
Risale al 1971 uno scritto di Pier Paolo Pasolini intitolato «La paura del naturalismo» (oggi, in «Empirismo eretico», Garzanti 1995, pp. 248-49), nel quale, riferendosi al cinema, Pasolini rifletteva proprio sull’utilizzo degli attori di strada. Da qualche anno, a far data dalla prima metà degli anni Sessanta, Pasolini interveniva in quel dibattito pubblico con articoli e saggi sulla definizione di una «generale semiotica del cinema» (segnalo, per esempio, le sue riflessioni sulla sceneggiatura in quanto genere letterario nuovo e autonomo, che furono inizialmente pubblicate come saggio su «Nuovi Argomenti» nel 1965, e che oggi sonoleggibili nello stesso volume Garzanti già citato, alle pp. 188-197), nella consapevolezza pasoliniana, ma che era anche del Moravia scrittore e uomo di cinema, espressa più volte già qualche decennio prima, rispetto a Pasolini, e cioè che il neorealismo cinematografico (da Roma città aperta, di Rossellini, del 1945), avesse prefigurato «tutto il neorealismo italiano letterario del dopoguerra e di parte degli anni Cinquanta».
Nel saggio «La paura del naturalismo», che è al fondo, evidentemente, della successiva polemica con Andrea Camilleri, per la messa in scena del suo Pilade, Pasolini così scriveva (in cordiale sfottò con Moravia e con Bertolucci):
Tutti sostengono che il cinema è sostanzialmente naturalistico.
Io oso infatti dire: «Se attraverso il linguaggio cinematografico io voglio esprimere un facchino, prendo un facchino vero e lo riproduco: corpo e voce»
[…]
Ma perché, perché tanta paura del naturalismo? Cosa nasconde questa paura? Non nasconderà, per caso, la paura della realtà? E non sono gli intellettuali borghesi che hanno paura della realtà? […]
Noi borghesi siamo tutti razzisti. Ora, io non voglio esserlo. E voglio che un facchino sia un facchino: cioè voglio che non sia né un’immagine che mi piace, né il portavoce della mia filosofia.
Il facchino del cinema è lo stesso facchino della realtà, dunque: e poiché il cinema è una tecnica audiovisiva, il facchino del cinema si presenta e parla come nella realtà […]. È naturalistico scegliere un facchino in carne e ossa, vero com’è vero uno qualsiasi di noi in questo momento che siamo vivi, con le sue parole, il suo linguaggio, la sua pronuncia […].