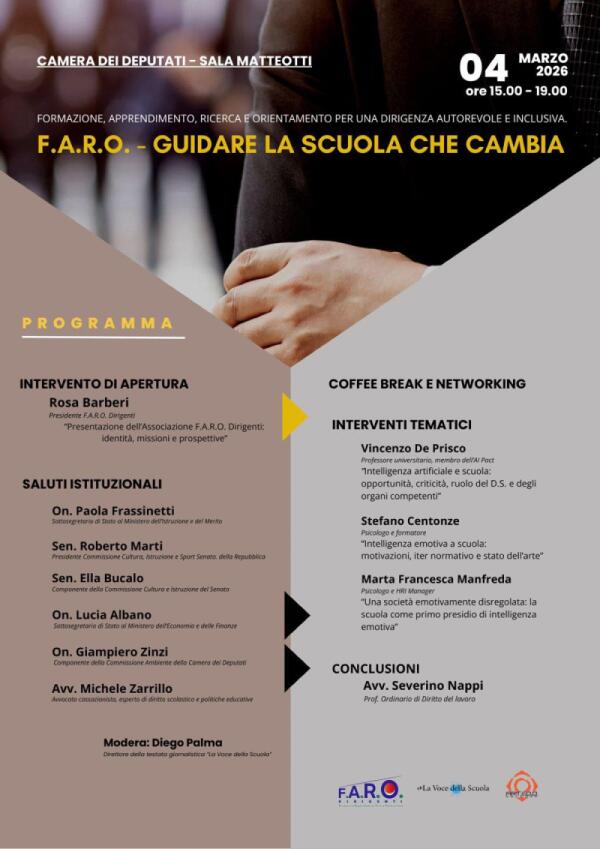Il docente di sostegno come professionista dell’inclusione
La professoressa Alessandra Patti spiega come la conoscenza normativa, la co-progettazione educativa e la consapevolezza professionale possano rendere la scuola davvero inclusiva
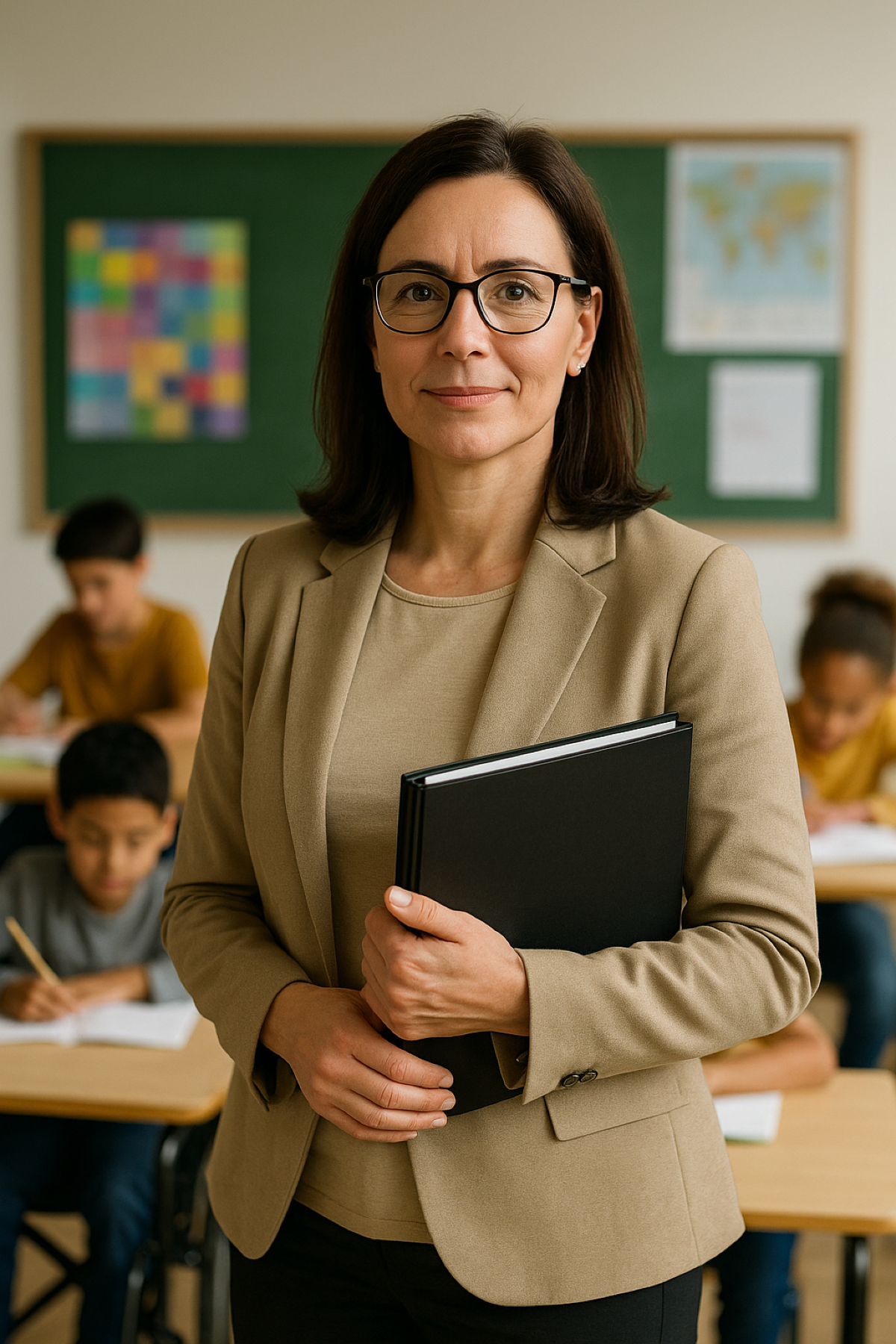

Nel corso di specializzazione per il sostegno viene dato ampio spazio alla conoscenza del sistema normativo relativo all’inclusione scolastica. In che modo, secondo lei, la padronanza di questo quadro legislativo può trasformarsi in un supporto concreto per i docenti, soprattutto nei casi più complessi di disabilità?
La conoscenza del quadro normativo sull’inclusione scolastica è uno strumento professionale fondamentale per tutti i docenti, perché consente di tradurre i principi di equità e partecipazione in pratiche educative concrete. Chi conosce l’evoluzione legislativa sa interpretare il contesto socio-culturale e muoversi con consapevolezza tra ruoli e responsabilità. Questa competenza si traduce nella capacità di tutelare i diritti degli alunni, mediare con colleghi e famiglie e attivare risorse interistituzionali. In sostanza, conoscere la normativa significa agire con consapevolezza, autonomia e responsabilità, coniugando diritto e pedagogia per garantire a ciascun alunno il pieno accesso all’apprendimento.
Uno degli obiettivi centrali del percorso formativo riguarda la progettazione educativa e la valutazione formativa. Quali strumenti e metodologie ritiene più efficaci per assicurare una piena coerenza tra il Piano Educativo Individualizzato (PEI), la programmazione didattica di classe e la valutazione degli apprendimenti degli alunni con bisogni educativi speciali?
Un elemento cardine per garantire coerenza tra PEI, programmazione di classe e valutazione è l’adozione di una progettazione condivisa, basata su una lettura comune dei bisogni e delle potenzialità dell’alunno secondo il modello bio-psico-sociale dell’ICF. Questa prospettiva permette di superare la visione assistenzialistica e di concentrarsi sul funzionamento globale della persona, considerando barriere e facilitatori presenti nei contesti di apprendimento.
Lo strumento più efficace è il Profilo di Funzionamento, che rappresenta la base conoscitiva e dinamica per la costruzione del PEI. Quest’ultimo non deve essere un mero documento formale, ma un vero strumento operativo per il successo formativo e la realizzazione del progetto di vita dello studente. È essenziale lavorare in co-progettazione tra docenti curricolari e di sostegno, promuovendo un linguaggio comune e la condivisione di obiettivi educativi.
Parliamo ora del ruolo del docente di sostegno all’interno dell’organizzazione scolastica. Come può questa figura contribuire in modo concreto alla costruzione di una scuola realmente inclusiva, favorendo la collaborazione tra colleghi e una gestione condivisa dei processi educativi?
Il docente di sostegno è una figura di sistema, non “dell’alunno con disabilità”, ma un professionista dell’inclusione che opera per l’intera comunità scolastica. Il suo contributo si fonda sulla co-responsabilità educativa e sulla collaborazione interprofessionale. Sul piano organizzativo, partecipa alla progettazione collegiale, contribuendo a diffondere una cultura dell’attenzione ai bisogni educativi di “tutti e di ciascuno”. È il fil rouge che connette docenti, famiglie e operatori sanitari e sociali, favorendo la comunicazione e la costruzione di una rete di corresponsabilità. In tal modo, diventa un vero motore di cambiamento organizzativo e culturale.
Infine, professoressa, sulla base della sua esperienza di formatrice, quali sono le difficoltà più ricorrenti che i futuri insegnanti di sostegno incontrano nel passaggio dalla teoria alla pratica inclusiva quotidiana, e quali strategie suggerirebbe per affrontarle con consapevolezza e professionalità?
Una delle difficoltà più frequenti è la fatica nel tradurre i principi inclusivi in pratiche quotidiane, soprattutto nei contesti complessi dove tempi, risorse e relazioni rendono difficile mantenere la visione sistemica appresa in aula. I docenti si trovano spesso a gestire un eccesso di aspettative e a ridefinire il proprio ruolo come risorsa per l’intera classe. Non è sempre facile costruire relazioni collaborative stabili con colleghi e famiglie.
Per affrontare queste sfide, è cruciale coltivare la dimensione riflessiva dell’agire educativo, valorizzare il lavoro di team, aggiornarsi sulle metodologie inclusive e promuovere una cultura dell’empatia professionale. Il passaggio dalla teoria alla pratica richiede tempo, accompagnamento e una comunità di intenti educativi.
Come amo ricordare agli studenti, la parola chiave è consapevolezza: la professione docente non è una missione, ma una scelta responsabile che richiede competenze solide e una motivazione da rinnovare ogni giorno, per non perdere di vista il senso e la finalità educativa del proprio impegno.