Omaggio a Carlo Levi, a cinquant’anni dalla morte
Saluto il 2025 con un estremo omaggio a Carlo Levi, morto il 1975, esattamente cinquant’anni fa, e lo faccio ricorrendo non al suo celeberrimo e celebratissimo Cristo si è fermato a Eboli

Saluto il 2025 con un estremo omaggio a Carlo Levi, morto il 1975, esattamente cinquant’anni fa, e lo faccio ricorrendo non al suo celeberrimo e celebratissimo Cristo si è fermato a Eboli, sul quale l’autore è rimasto, ingiustamente, schiacciato a vita (ma anche post-mortem), fino a far dimenticare altre sue opere letterarie di grande pregio, come, per esempio, L’orologio, uscito presso Einaudi nel 1950 (ancora una data tonda: 75 anni fa), che conserva tutto il suo valore politico e tutto il suo fascino letterario di dolente riflessione sul tradimento degli ideali della Resistenza.
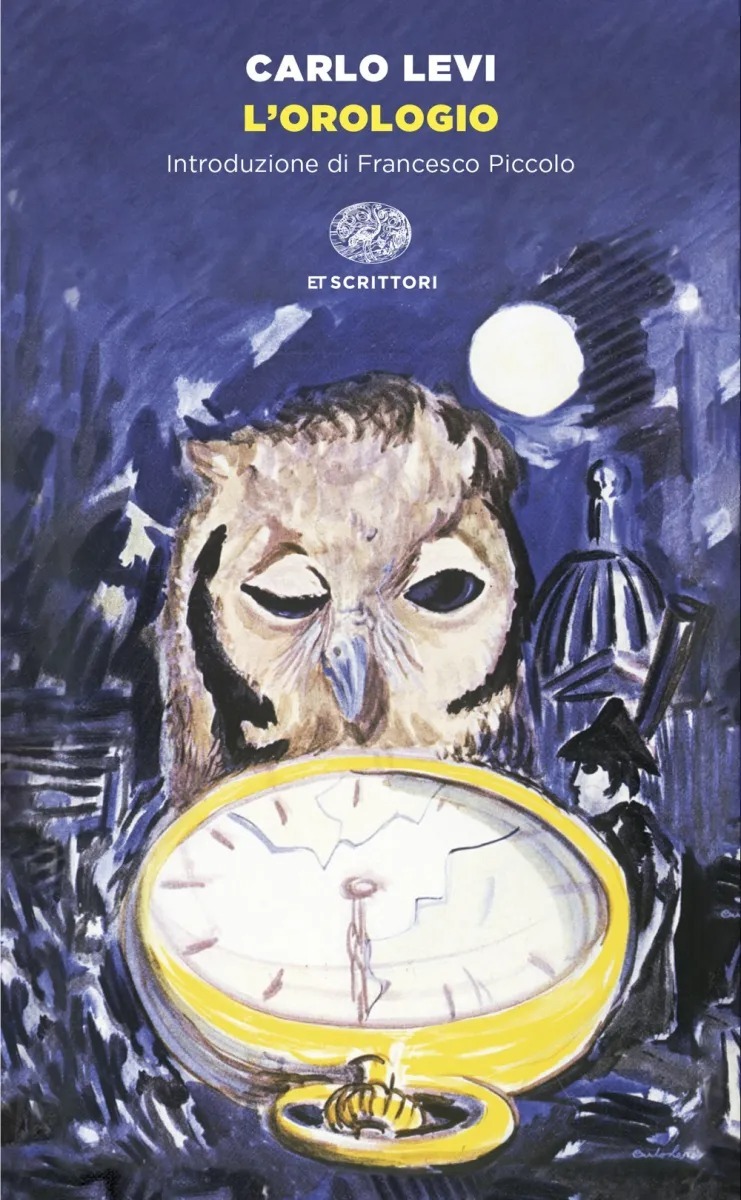
L’orologio è il racconto dilatato di tre giorni e tre notti del 1945, precisamente dal 24 al 26 novembre, ambientato a Roma, dove l’io-narrante è giunto per dirigere un giornale (Carlo Levi, in effetti, a Roma, fu chiamato in quei giorni per dirigere «L’Italia libera», organo del Partito d’Azione, a ridosso delle dimissioni del Capo del Governo Ferruccio Parri, avvenute il 24 novembre 1945, durato in carica solo 172 giorni, formalmente, dal 21 giugno, al 10 dicembre, per un totale di 5 mesi e 19 giorni), con la conseguente delusione per tutte le speranze di rinnovamento politico (e morale) dell’Italia post-fascista, che faticava a mettere i suoi primi passi. Ferruccio Parri, che era stato comandante partigiano, ed esponente del Partito d’Azione, aveva presieduto il primo governo dopo la Liberazione dal nazi-fascismo, con il concorso di tutti i neo-ricostituiti partiti del CLN (Comitato di Liberazione Nazionale), con l’ambizione etico-politica di rappresentare un inizio per il Paese, nel segno della rottura con il Ventennio fascista (e con gli orrori della guerra). Oltre che a una profonda e sostanziale riforma dello Stato (in ambito sociale, economico, industriale, agrario, etc.), il Governo Parri si pose l’obiettivo di preparare le condizioni politiche e culturali per l’avvio della Costituente, in difesa della laicità dello Stato e della sovranità nazionale (superamento della forma monarchica, e netta distinzione tra Chiesa e Stato). Il Governo Parri, però, entrò in crisi dopo pochi mesi, per l’ostruzionismo messo in atto dai grandi partiti di massa, come la Democrazia cristiana e il PSIUP (Partito Socialista Italiano di Unità Proletaria).
Un po’ romanzo e un po’ memoir, quest’opera è incentrata sul racconto di tre giorni e tre notti che cambiarono il corso della storia d’Italia. In realtà, il tempo del racconto de L’orologio di Carlo Levi, che prende l’avvio grazie all’espediente narrativo di un orologio che si rompe, grazie alla tecnica del flash-back, si dilata in un intorno narrativo di almeno cinque anni, rispetto alla cronaca di quei tre giorni (con affondi anche più lontani nel tempo, verso gli anni della guerra, vissuti da Levi a Firenze, dove trovò rifugio presso l’abitazione di Anna Maria Ichino, in piazza Pitti, nel libro ricordata semplicemente con il nome di Maria, condividendo il rifugio con personalità del calibro di Eugenio Montale e di Umberto Saba). Dunque, un racconto in forma di diario privato dei giorni della crisi del Governo Parri, e della fine delle grandi ambizioni culturali, etiche e politiche della Resistenza. Tra le prime testimonianze di quella delusione e di quel tradimento, questo libro di Carlo Levi resta, ancora oggi, una lettura fondamentale, per chi voglia capire la natura e il senso più profondo e autentico di una crisi istituzionale, culturale, sociale e morale nella quale siamo ancora immersi, fino agli odierni attacchi alla Costituzione:
Il Presidente dimissionario aveva convocato i membri del Comitato di Liberazione, gli uomini politici, i giornalisti italiani e stranieri, per fare, davanti ad essi, una dichiarazione. Era una procedura senza precedenti nelle abitudini parlamentari e governative: ma anche le condizioni nelle quali i fatti si svolgevano erano senza precedenti, in un periodo di transizione e di formazione, dove tutto era imprevisto, e non esistevano organi, né tradizionali né nuovi, la cui esistenza fosse certa e duratura. Nulla, nella piazza o nel Ministero, segnava tuttavia la gravità o la solennità del momento. Non c’erano truppe schierate, né forze di polizia […].
Soltanto gli uscieri del Ministero (simbolo e figura degli eterni burocrati) sembravano godere, in segreto, di quella crisi, con «un’aria stranamente allegra»:
Non avrebbero più dovuto trepidare al pensiero di folli riforme, di insensati cambiamenti, di crudeli epurazioni, di ridicole pretese di efficienza […].
Lo stesso Ferruccio Parri, da costoro, è percepito ed è visto come un «diverso, come straniero»:
...nessuno avrebbe potuto contemplare e adorare in lui […] i propri vizi e le proprie virtù: tra gente esuberante, era schivo; in un paese amante della retorica e delle frasi, era scarno e ritroso […]. Aveva il viso sofferente, come se un dolore continuo, il dolore degli altri che non può aver fine, gli volgesse in basso gli angoli della bocca, gli spegnesse lo sguardo, e gli avesse, fin da fanciullo, imbiancato i lunghi capelli […]. Egli era fatto della incorporea materia dei santi […].
Esponeva quello che s’era fatto in quei mesi, come un cancelliere accurato che legga il verbale di una seduta precedente: ma quello che diceva, sotto la veste convenzionale, non stava alle regole. Era una specie di atto di accusa, mite e senza perdono, contro coloro che avevano cercato di capovolgere gli avvenimenti, di rompere a proprio vantaggio quella unità del cui dolente valore egli si sentiva il custode […]. La diagnosi era dura, e esatta: ritorno di un vecchio mondo, tentativo di annullare tutto quello che era stato fatto, e, infine, la grande parola: colpo di stato.
[alle pp. 148-150]
Il critico Filippo La Porta, di recente, ha scritto, a ragione, che questo romanzo di Carlo Levi è da considerare come il «più importante romanzo politico del secondo dopoguerra, romanzo struggente sul tradimento della Resistenza scritto da azionista, cospiratore e partigiano». Di grandissimo effetto narrativo (e politico), nel libro di Levi, la doppia metafora dei «contadini» e dei «luigini», che l’autore inventa per spiegare, dal di dentro della tradizione italiana, la crisi del neo-nato Stato post-fascista:
Eravamo partiti che volevamo la rivoluzione mondiale, poi ci siamo accontentati della rivoluzione in Italia, e poi di alcune riforme, e poi di partecipare al Governo, e poi di non esserne cacciati. Eccoci oramai sulla difensiva: domani saremo ridotti a combattere per l’esistenza di un partito, e poi magari di un gruppo o di un gruppetto, e poi, chissà, forse per le nostre persone, per il nostro onore e la nostra anima: cose sempre più piccole e più lontane […]. È triste: ma vedrai che andrà così […]. Siamo stati sconfitti, per molte ragioni che non dipendono da noi, ma anche per colpa nostra, che non sapevamo quello che si dovesse volere, e giocavamo a fare i Machiavelli, e abbiamo preteso di fare le riforme di struttura conservando o restaurando proprio quella struttura che volevamo riformare […].
Le due Italie, sono quella dei Contadini e quella dei Luigini. Contadini e Luigini […] ecco i due movimenti, nemici e impenetrabili; ecco le due sole Categorie della nostra storia. Contadini e Luigini, Luigini e Contadini […]. I Luigini, chi sono? Sono la grande maggioranza della sterminata, informe, ameboide piccola borghesia, con tutte le sue specie, sottospecie e varianti, con tutte le sue miserie, i suoi complessi d’inferiorità, i suoi moralismi e immoralismi, e ambizioni sbagliate, e idolatriche paure. Sono quelli che dipendono e comandano; e amano e odiano le gerarchie, e servono e imperano. Sono la folla dei burocrati, degli statali, dei bancari, degli impiegati di concetto, dei militari, dei magistrati, degli avvocati, dei poliziotti, dei laureati, dei procaccianti, degli studenti, dei parassiti […]. E anche gli industriali e commercianti che si reggono sui miliardi di Stato, e anche gli operai che stanno con loro, e anche gli agrari e i contadini della stessa specie. Tutti questi sono i Luigini. Poi ci sono i politicanti […]: comunisti, socialisti, democristiani, azionisti, liberali, qualunquisti, neofascisti, di destra e di sinistra, rivoluzionari o conservatori o reazionari […]. E aggiungete infine, per completare il quadro, i letterati, gli eterni letterati dell’eterna Arcadia, anche se, per fortuna, non sanno né leggere né scrivere. [I Contadini] sono una grande forza che non si esprime, che non parla. Il problema è tutto qui. La lingua degli altri, il loro Stato, bandiere, partiti, non conviene a loro: non ha senso sulle loro bocche. Devono parlare, ma a modo loro. Finora non ci sono mai riusciti. Quello che dico, è tutt’altro che una novità o una scoperta. Molti lo hanno detto, in altri termini, un po’ in tutti i tempi. Lo diceva già, dal suo punto di vista, Machiavelli, che era un Contadino, e perfino Guicciardini. In tempi più vicini […]: Gramsci, Gobetti, De Viti de Marco, i liberisti antigiolittiani, Salvemini, Giustino Fortunato, l’abate Padula, Dorso e i meridionalisti, quelli del Partito d’Azione e tanti popolani ignoti e senza nome […]. La verità è che la forma stessa dei nostri partiti è luigina, la tecnica della lotta politica e la struttura del nostro Stato sono luigine.
[alle pp. 159-168]
Come non sentire, in alcuni passaggi di queste parole di Carlo Levi, il Pasolini di qualche anno dopo, nel film «La ricotta» (1963), che evidentemente ne tenne conto per confezionare la scena intervista, con Orson Welles, sulla borghesia italiana, analfabeta e ignorante. Come pure, per quanto riguarda la inesistente lingua dei «Contadini», incapaci, appunto, di esprimersi, ravvisare nelle parole di Levi la presenza di quell’idea che Pasolini avrebbe rilanciato, qualche anno dopo, sul così detto «genocidio» della cultura contadina (della sua lingua, e della sua visione del mondo e dell’uomo). Ma anche le riflessioni, sempre di qualche anno successivo, rispetto al libro di Carlo Levi, di don Lorenzo Milani, contenute nella sua Lettera a una professoressa (1967), sulla lingua dei padroni e sulla lingua degli operai, e sulla necessità, da parte degli operai e dei contadini, di possedere più vocaboli dei padroni, per poter parlare (il padrone conosce 1000 parole, l’operaio soltanto 100).
Chi volesse rivedere la scena de La ricotta, di Pier Paolo Pasolini, potrebbe far click sul seguente link:



