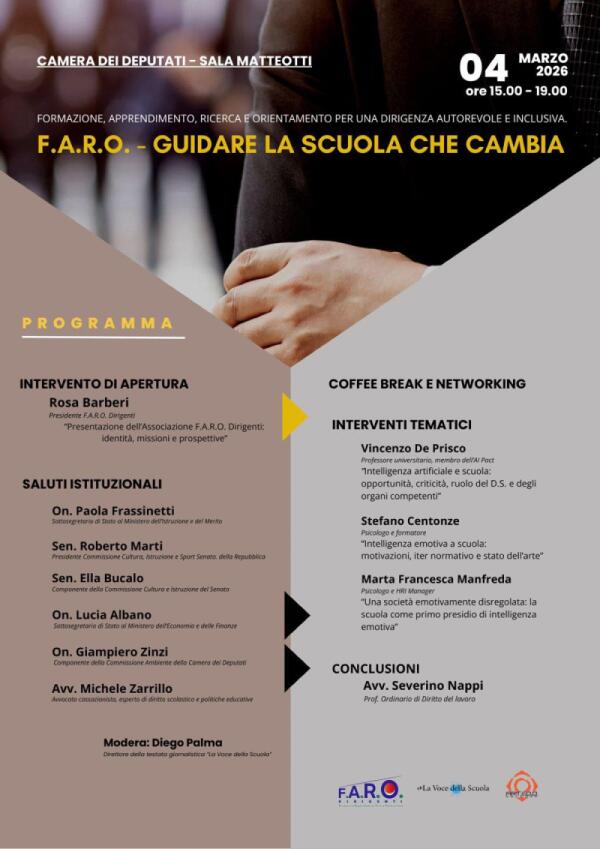Noterelle per un (inedito) Beppe Fenoglio sportivo
Nella memoria collettiva, il nome di Beppe Fenoglio (1922-1963) è legato, quasi esclusivamente, alla lotta partigiana, di cui fu protagonista in prima persona, e ai racconti e ai romanzi della resiste...

Nella memoria collettiva, il nome di Beppe Fenoglio (1922-1963) è legato, quasi esclusivamente, alla lotta partigiana, di cui fu protagonista in prima persona, e ai racconti e ai romanzi della resistenza, appunto, contro il nazi-fascismo. È noto il giudizio di Italo Calvino, secondo il quale la Resistenza italiana avesse trovato proprio in Beppe Fenoglio il suo cantore. Del resto, Calvino seguì l’esordio di Fenoglio scrittore, per conto della casa editrice Einaudi, in quanto giovane redattore Einaudi, incoraggiandolo, con questa parole, in una lettera datata 2 novembre 1950:
Caro Fenoglio,
ho letto La paga del sabato […]. Ti dico subito quel che penso: mi sembra che tu abbia delle qualità fortissime; certo anche molti difetti, sei spesso trascinato nel linguaggio, tante piccole cose andrebbero corrette, molte cose urtano il gusto – specie nelle scene amorose – e non tutti i capitoli sono egualmente riusciti.
Però sai centrare situazioni psicologiche particolarissime con una sicurezza che davvero mi sembra rara […].
Non ultimo merito è quello di documento della storia di una generazione; l’aver parlato per la prima volta con rigorosa chiarezza del problema morale di tanti giovani ex partigiani […].
Ora non posso dirti niente su eventualità di pubblicazione o altro. Tu sarai ansioso, lo capisco, ma devi ancora aver pazienza. Lo leggeranno altre persone. Io ti ho detto quel che ne penso io personalmente.
Ti farò sapere qualcosa presto. Tu sta in gamba e continua.
Cari saluti.
Quel libro (La paga del sabato) non si fece, per alcune perplessità di Elio Vittorini, direttore della collana einaudiana dei «Gettoni», nella quale il libro sarebbe dovuto entrare. Fenoglio ne ricavò due distinti racconti, Ettore va al lavoro, e Nove lune. Solo molti anni dopo, nel 1969, il romanzo sarebbe uscito nella sua unità e integrità narrativa, nella colla «Supercoralli» di Einaudi, postumo, dunque, e con la curatela di Maria Corti. Calvino stesso, nel tentativo di convincerlo, scrisse a Vittorini una lettera, il giorno 8 novembre 1950, pochi giorni dopo rispetto a quella scritta a Fenoglio, dicendogli:
Caro Elio,
ti mando il manoscritto de La paga del sabato, di un certo Beppe Fenoglio di Alba […]. È un libro che ha molti difetti di lingua e di gusto (in certi punti rasenta la pornografia); ma tutti difetti locali, eliminabili con poche correzioni. E ne salta fuori un robusto narratore, fuori da ogni compiacimento letterario, con un sacco di cose da dire […].
L’argomento era molto difficile da trattare: ex partigiani che diventano banditi; e lui spiega tutto coi fatti, con una moralità tutta implicita […].
Insomma, spero che ti piaccia e che vada bene per la tua collana, perché – benché possa essere considerato un «neorealista» di stretta osservanza – non rifà il verso a nessuno e dice delle cose nuove.
Beppe Fenoglio fu, dunque, scrittore e partigiano, come volle lui stesso che si scrivesse sulla sua lapide, traduttore dall’inglese, lingua per la quale, sin dall’adolescenza, aveva provato un totale trasporto. Nelle sue opere, tanti nei racconti, quanto nei romanzi, non solo abbondano vocaboli ed espressioni in lingua inglese, ma anche molti nomi dei suoi personaggi (alter ego di sé stesso) sono inglesi (Milton Johnny, e così via). Del grande romanzo Il partigiano Johnny è giunta una redazione totalmente scritta da Fenoglio in inglese.
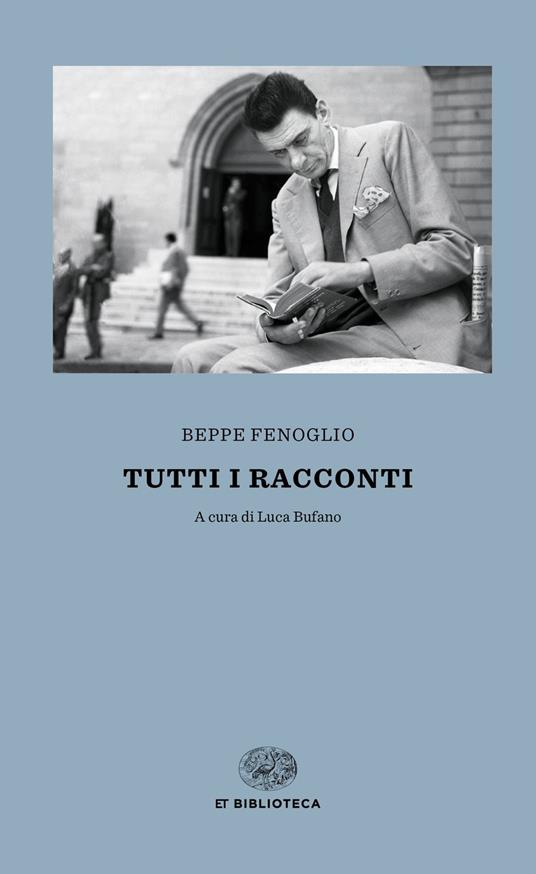
In questo mio primo intervento critico sull’opera letteraria di Beppe Fenoglio lascio tutto questo (e tanto altro ancora) in penombra, riservandomi, a breve, di tornare con un lavoro organico, al quale, evidentemente, sto già lavorando (da mesi), per metter in luce, piuttosto, un aspetto trascurato della personalità di Fenoglio, e cioè la sua dimensione sportiva. Noterelle per un (inedito) Beppe Fenoglio sportivo ho voluto, infatti, intitolare questo mio intervento, dedicandolo, innanzitutto, ai miei studenti del corso di studi SAMS, di Bari, per il mio insegnamento “Lo sport nella letteratura”, e a quanti altri lettori amino l’opera di Beppe Fenoglio.
Era un uomo alto, con il fisico asciutto e il viso scavato. Di lui, ha scritto la sorella Marisa Fenoglio che…
Beppe aveva una faccia intensa, classica, ma butterata come avesse fatto il vaiolo […], mortificata da un naso rosso, ciranesco, lui che era astemio! […].
Ma nonostante questo, una faccia bellissima, animata da una febbre intensa, sprigionante dagli occhi tristi e ironici, duri e ansiosi…
Ecco un altro “ritratto” di Beppe, firmato dalla moglie, Luciana Bombardi:
Un ragazzo alto, distinto, sempre in giacca e cravatta. Non proprio bello, ma affascinante: si faceva notare in compagnia, attirava l’attenzione e l’interesse di tutti. Se non sposavo lui, non sposavo nessuno.
Con un fisico simile, alto e asciutto, Beppe Fenoglio non poteva non praticare la pallacanestro. A diciotto anni, era alto un metro e ottantadue (che, per quei tempi, era una statura alta). Nei ricordi di suo fratello Walter, Beppe «era uno sportivo nel senso culturale: gli piaceva l’agonismo e accettava la sconfitta come la vittoria». E questo è un dettaglio importante, saper accettare, nello sport come bella vita, innanzitutto, la sconfitta, prima e più della vittoria. Oltre alla pallacanestro, Beppe praticava anche il nuoto, ma non quello di mare (o di piscina), bensì quello di fiume, di gran lungo più difficile e impegnativo (e pericoloso). Amava giocare a scopone (ed era temuto, per questo); così, pure, seguiva il calcio, a Torino. Ma più d’ogni sport, Fenoglio seguiva con passione sincera e profonda il pallone elastico, che era il gioco della sua terra, delle sue parti. E lo praticava pure. Così forte questa passione da inserirla in un suo racconto, nella terza parte de Il paese:
Augusto Manzo, , campione italiano di pallone elastico, era arrivato da Alba su un’auto di piazza per visionare Sergio. La macchina si era parcheggiata a lato della chiesa, davanti alla privativa di Placido, e il campione stava procedendo verso il centro della piazza. Come stava dicendo con la sua voce lenta e mansueta, il suo terzino destro di quadriglia era stato operato all’improvviso di ernia e non aveva sostituto per finire il campionato. Così era venuto a questo paese per visionare Sergio, del quale aveva sentito chissà come parlare. – È una buona scelta, – disse Fresco, che tra l’altro era zio secondo di Sergio. – Dove abita questo Sergio? – domandò il campione, torreggiando sul codazzo degli ammiratori. Fresco gli indicò la casa di Sergio, ma disse che stava da Umberto, perché l’aiutava nel servizio postale. – Dov’è l’ufficio postale? – domandò allora manzo. – Non scomodatevi, ci saranno già andati in dieci a chiamarlo.
Era un uomo altissimo, e con un gonfio torace, e la spalla destra sensibilmente più alta dell’altra. Quando poi per il caldo si rimboccò le maniche, videro che il suo avambraccio destro era grosso e tubolare come un mattone, sparito il polso. – È su questa piazza che giuocate, vero? – domandò con la sua voce lenta e mansueta. I suoi capelli erano chiari come il suo occhio. – Sì, – disse Fresco, – e se salite sul mio balcone a veder la partita, io sarò onorato […].
L’espressione «pallone elastico» è stata in uso fino al 2001, allorquando, cioè, è stata sostituita dalla dicitura «pallapugno». In Piemonte (ma anche in Liguria), terre dove era (ed è) praticato questo gioco, veniva chiamato anche «balùn». Si tratta di un gioco sferistico, svolto a squadra, su di un terreno piano, con un muro di rimbalzo (o anche con una rete di rimbalzo). Il gioco deriva dall’antichissima «palla a muro». Un suo primo regolamento risale al 1555, con l’intenzione di disciplinare questo gioco a palla. L’area di radicamento del pallone elastico ( o pallapugno) è il basso Piemonte (e la riviera di Ponente, in Liguria), dove viene pratico a livello professionistico. Con il Novecento, questo gioco, come altri, del resto, ha vissuto una forte crisi, con conseguente ridimensionamento, sotto i colpi inferti dall’arrivo, in Italia, del football, e di altri giochi sferistici inglesi. Il pallone elastico è sempre stato sport popolare, contadino, in modo particolare, di tradizione (piemontese e ligure). Ha trovato in molti scrittori d’area i suoi cantori, ed estimatori. Oltre a Beppe Fenoglio, vanno ricordati, almeno, Edmondo De Amicis, Cesare Pavese, Giovanni Arpino, e altri. Il gioco si svolge tra due squadre di quattro giocatori ciascuna, dette, appunto, quadrette: battitore, spalla e due terzini. Il campo, altrimenti detto sferisterio, era di terra battuta, fiancheggiato da un muro d’appoggio (per il colpo di rimbalzo), e con una rete di chiusura, al di sopra. La palla di gioco è di gomma. I punti vengono contati come nel tennis: quindici, trenta, quaranta, gioco. Il battitore è il giocatore, di norma, atleticamente più forte. Gli avversari possono rispondere colpendo la palla al volo, o dopo il primo rimbalzo (come nel tennis), colpendo con il pugno (protetto da fasciature).
Augusto Manzo, nato a Santo Stefano Belbo nel 1911, morto ad Alba nel 1982, è stato ben otto volte campione d’Italia, ed è considerato come il più completo e forte giocatore di pallone elastico di tutti i tempi. Ha sempre ricoperto il ruolo del battitore, e viene universalmente ricordato per le sue grandissime doti di atleta e per lo stile di gioco. Praticò pure, con successo, la «palla con il bracciale», e fu acclamato nei maggiori sferisteri del tempo, aggiudicandosi centinaia di trofei, coppe e medaglie. Morì a 71 anni, nel 1982, per le conseguenze di un incidente automobilistico.
Beppe Fenoglio praticò pure il calcio, così come ricorda Giorgio Bocca, avendolo avuto avversario in una partita disputata nel 1937 (o 1938):
Ero un ragazzino, uno studente che cercava di giocare di fino in mezzo alle pestate del calcio provinciale. Appena toccavo palla udivo l’ansito rauco e minaccioso di mediani e terzini abituati alla regola virile: prima le gambe, poi la palla […]. Una domenica si gioca ad Alba […]. Aria da fiera, pubblico riscaldato dal vino, subito calcioni furibondi e la lieta ferocia della folla. Così almeno mezza ora senza quasi toccare palla. Finalmente una palla buona, un dribbling liberatore, un tiro elegante che lambisce un palo e nel silenzio un “bravo Giorgio”, deciso e altero, da amico che ti si mette al fianco contro i molti. Un attimo per voltarmi e riconoscere in quel ragazzo alto e magro uno di quelli su cui misuri la tua vita, un provinciale del tuo destino.