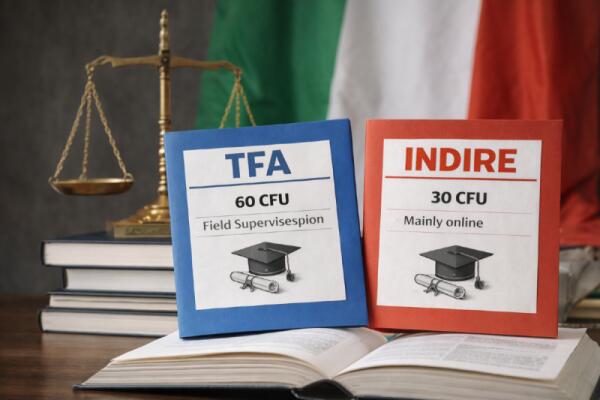Gestione delle crisi d'ansia nel bambino autistico in Pronto Soccorso: strategie e interventi
Il meltdown rappresenta una risposta fisiologica e involontaria che si manifesta in individui, in particolare quelli con disturbo dello spettro autistico

Comprendere il Meltdown: una risposta involontaria
Il meltdown rappresenta una risposta fisiologica e involontaria che si manifesta in individui, in particolare quelli con disturbo dello spettro autistico, quando si trovano di fronte a un accumulo eccessivo di stimoli che generano frustrazione e sopraffazione. Questo stato di “overload” sensoriale, emotivo o sociale culmina in una reazione di crisi, dove il corpo funge da veicolo per esprimere un disagio che non può essere verbalizzato.
Per un soggetto autistico, il mondo può spesso apparire come un ambiente incomprensibile e imprevedibile. La realtà esterna e quella interiore possono generare sentimenti di vulnerabilità, accentuati dall’impossibilità di una verbalizzazione intenzionale e controllata. In tali circostanze, l’agito diventa l’unica modalità per comunicare il proprio turbamento. L’angoscia e l’insicurezza, specialmente di fronte alla novità, possono tradursi in una scarica motoria ripetuta e afinalistica, il cui controllo risulta estremamente difficile. È cruciale comprendere che, sebbene possa apparire aggressivo, questo “acting out” non è motivato da intenti distruttivi, ma dall’esigenza profonda di comunicare un disagio interiore.
Fattori scatenanti: l’eccesso di stimoli
L’ambiente, per un soggetto autistico, presenta una soglia di tollerabilità piuttosto bassa, facilmente superabile da stimoli non precedentemente familiarizzati. Qualsiasi mutamento ambientale non anticipato può indurre uno stato di allarme, compromettendo la capacità di coping assertivo e generando un senso di smarrimento. L’eccesso di stimoli che può condurre a un meltdown può derivare da diverse fonti:
Stimoli ambientali/sensoriali: un sovraccarico di sollecitazioni esterne, come ambienti eccessivamente rumorosi o affollati, o l’esposizione a temperature estreme (troppo calde o troppo fredde).
Stimoli emotivi: l’esperienza di vissuti affettivi intensi, disforici o ansiogeni. Stimoli sociali: la necessità di affrontare impegni o dimostrare competenze percepite come superiori alle proprie capacità, come la partecipazione a lavori di gruppo, giochi o eventi pubblici.
Alterazioni della routine: la modifica di abitudini consolidate, l’insorgere di un imprevisto o un cambiamento imposto dall’esterno possono destabilizzare profondamente l’individuo.
Segnali premonitori: lo “Stimming”
Prima che un meltdown si manifesti pienamente, possono comparire segnali premonitori. Tra questi, lo “stimming” (stereotipie auto-regolative) riveste un ruolo cruciale. Comportamenti come dondolii, sfarfallio delle mani o la ripetizione reiterata di gesti specifici sono messi in atto dal soggetto per placare l’ansia o per regolare stati emotivi disorganizzati in situazioni di crescente disagio. Lo stimming rappresenta un tentativo di autoregolazione di fronte a un imminente sovraccarico.
Manifestazioni tipiche del Meltdown
Quando l’accumulo di stimoli supera la capacità di elaborazione e gestione dell’individuo, si verifica il meltdown. Le manifestazioni tipiche includono:
Crisi di pianto e urla: espressioni sonore intense di angoscia e frustrazione.
Scariche motorie ripetute: Movimenti involontari e spesso afinalistici.
Condotte di auto-lesionismo: Comportamenti volti a infliggere danno a sé stessi (es. mordersi, colpirsi la testa).
Condotte di etero-lesionismo: Comportamenti volti a infliggere danno ad altri (es. spingere, graffiare).
Queste manifestazioni possono verificarsi in contesti sia familiari che non familiari, e la loro durata è spesso imprevedibile. Il soggetto, sopraffatto dall’eccesso di dati sensoriali, emotivi o sociali, perde ogni capacità di coping assertivo, sentendosi letteralmente “perso”. In questi momenti, l’agito diventa l’unico sistema di controllo e regolazione, destabilizzando ulteriormente la risposta dell’organismo.
È essenziale ricordare che il meltdown non è un capriccio o una manifestazione di cattiva volontà, ma l’esito di un profondo disagio comportamentale legato alle caratteristiche intrinseche del disturbo autistico, come una bassa soglia di tollerabilità allo stress, deficit comunicativi e difficoltà nella regolazione del Sé.
Shutdown: il ritiro difensivo e il "Freezing"
Descrizione generale
Lo shutdown è una reazione neurologica passiva che si manifesta come una risposta di ritiro in situazioni di sovrastimolazione o minaccia percepita. Questo fenomeno è caratterizzato da silenzio, apparente immobilità e una difesa dissociativa che mira a distaccare l’individuo dall’eccesso di stimoli. Spesso si osserva una deflessione timico- motoria che può portare a uno stato di immobilità quasi totale, con una ridotta o assente risposta agli stimoli esterni e, talvolta, comportamenti regressivi. Questo stato è anche noto come “freezing” e rappresenta un incapsulamento volto a proteggere la persona da stimoli ingestibili.
Incapsulamento e fusione tra mente e corpo
L’incapsulamento è il meccanismo difensivo centrale nello shutdown. Quando una situazione, sia essa endogena o esogena, minaccia di superare la soglia di tolleranza individuale, l’organismo attiva un blocco emotivo-posturale. Questo blocco ha lo scopo di distaccare l’individuo dai canali sensoriali che potrebbero innescare una cascata di difese (pensiero, emozione, azione) non gestibile nel momento presente. In questo stato, il soggetto può apparire silenzioso, rifiutare la comunicazione, chiudersi su sé stesso o raggomitolarsi, spesso con le mani sulle orecchie e gli occhi chiusi. L’obiettivo è creare un rifugio interno, un “buco” temporale in cui la persona non venga invasa da stimoli potenzialmente destabilizzanti.
Implicazioni Relazionali e Comunicative
Lo shutdown ha diverse implicazioni sul piano relazionale e comunicativo:
Ritiro e distacco: Durante lo shutdown, la persona può diventare non contattabile dai contenuti esterni. La risposta emotiva è bloccata e la mimica facciale ridotta, portando a un isolamento fisico. Competenza temporaneamente perdute: In alcuni casi, si possono osservare segni regressivi di abilità precedentemente acquisite, come difficoltà a compiere azioni abituali (es. allacciare le scarpe). Impatto relazionale: Il blocco emotivo riduce la possibilità di scambiare informazioni e bisogni, aumentando la percezione di incomprensione da parte dell’ambiente e potenzialmente rinforzando l’isolamento se non gestito adeguatamente. Stato di letargia: Possono emergere stati letargici che ostacolano l’accesso emotivorelazionale, rendendo l’individuo poco reattivo agli stimoli e alle domande.