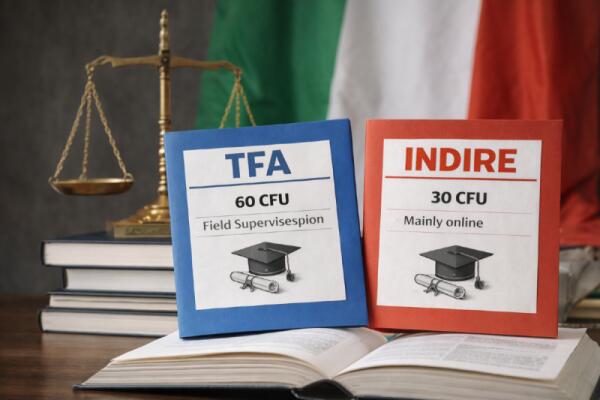Gestione delle crisi d'ansia nel bambino autistico in Pronto Soccorso: strategie e interventi
Il meltdown rappresenta una risposta fisiologica e involontaria che si manifesta in individui, in particolare quelli con disturbo dello spettro autistico

Condizioni innescanti e contesto
Lo shutdown può essere innescato da diverse condizioni:
1. Sovrastimolazione: Ambienti rumorosi, luci forti, affollamento, temperature scomode, cambiamenti improvvisi o la non prevedibilità dell’ambiente possono scatenare lo shutdown.
2. Sovraccarico sensoriale: Stimoli multipli e intensi che superano la capacità di elaborazione dell’individuo, spingendolo verso una difesa “offline”.
3. Fattori interni ed esterni: Sia cause interne (stato di ansia, stanchezza, disagio fisiologico) sia cause esterne (rumore, cambiamenti di routine, procedure mediche) possono contribuire all’insorgenza dello shutdown.
Differenze rispetto ad altre reazioni reattive
È importante distinguere lo shutdown da altre reazioni:
Confronto con il meltdown: Il meltdown è una crisi attiva, esplosiva e di tipo motorio, guidata da sovraccarico e frustrazione. Lo shutdown, al contrario, è passivo e difensivo, caratterizzato da regresso all’immobilità e al ritiro.
Distinzione dal tantrum: Il tantrum è un’espressione di protesta finalizzata a raggiungere un obiettivo o evitare una conseguenza negativa. Lo shutdown non mira a ottenere nulla attraverso l’espressione, ma a creare una via di fuga dagli stimoli.
Strategie di intervento e gestione pratica
In contesti educativi o sanitari, è fondamentale adottare strategie specifiche:
1. Vicinanza controllata: Offrire presenza senza invadere lo spazio vitale; evitare il contatto fisico che potrebbe aumentare il senso di minaccia.
2. Evitare rimproveri: Non stigmatizzare il comportamento; comunicare la necessità di interrompere l’azione in modo prudenziale e non giudicante.
3. Riconoscere e rimuovere le cause: Identificare lo stimolo scatenante e allontanarlo quando possibile; chiedere al soggetto come si è sentito e quali elementi del contesto hanno provocato disagio.
4. Prevenzione: Riconoscere i segnali di sovraccarico imminente e intervenire prima che la crisi si sviluppi (es. attenuare rumori, spostare in un ambiente meno stimolante).Niente panico: Mantenere la calma è cruciale. Evitare di alimentare l’ansia collettiva, imporre stimoli o discutere con urgenza.
5. Prevenzione: Riconoscere i segnali di sovraccarico imminente e intervenire prima che la crisi si sviluppi (es. attenuare rumori, spostare in un ambiente meno stimolante).
6. Utilizzo di oggetti calmanti: Ricorrere a oggetti preferiti (peluche, libri, oggetti antistress) o attività familiari per favorire un ritorno a uno stato di controllo.
7. Ristabilire fiducia nel coping: Riconoscere che la reazione è una risposta del disturbo, non una volontà dimostrativa; enfatizzare che con strategie adeguate è possibile gestire meglio le situazioni future.
8. Educare al futuro: Offrire strumenti di gestione dell’ansia, presentando modelli di reazione alternativi.
9. Non colpevolizzare: Eliminare sensi di stigma associati alla crisi; assicurarsi che il soggetto sappia di non essere giudicato per la reazione.
10. Niente panico: Mantenere la calma è cruciale. Evitare di alimentare l’ansia collettiva, imporre stimoli o discutere con urgenza.
11. Mettere in sicurezza: Se necessario, contenere comportamenti potenzialmente lesivi per la sicurezza del soggetto o degli altri, con misure mirate e proporzionate.
12. Empatia e comprensione: Accogliere il disagio, ascoltare senza giudizio e cercare di interpretare le cause percepite dall’altro, mantenendo un atteggiamento calmo e rassicurante.
Aspetti relazionali e comunicativi durante e dopo una crisi
Supporto di figura di riferimento: La presenza di una persona di fiducia (familiare o mediatore) è utile per favorire la comunicazione e calmare la situazione.
Pianificazione di intervento: Coinvolgere un team di supporto, definire ruoli chiari e attuare un piano di emergenza per migliorare l’esperienza in contesti ospedalieri o educativi.
Rinforzo positivo e spiegazioni: Dopo la crisi, offrire spiegazioni adeguate e strategie di coping più funzionali; utilizzare rinforzi positivi per rafforzare la fiducia nel proprio stile di regolazione.
Spazi dedicati e ambienti calmanti: Predisporre ambienti meno stimolanti in sedi ospedaliere o scolastiche per ridurre il carico sensoriale e facilitare la gestione della crisi.
Preparazione preventiva: Informare l’individuo su cosa accadrà in anticipo e utilizzare strumenti di comunicazione adatti (es. app o protocolli specifici) per aumentare la prevedibilità e la sicurezza.
Implicazioni Pratiche per Contesti Specifici
In ambito ospedaliero: Implementare protocolli e percorsi specifici per persone autistiche, potenziando l’accesso a spazi tranquilli e personale formato. L’uso di interfacce comunicative e di app dedicate può facilitare la preparazione alle procedure e ridurre l’ansia.
Prima di un intervento medico: Contattare la struttura per verificare percorsi autistici disponibili, predisporre un piano di supporto e informare il bambino in modo chiaro e progressivo. Un piano di emergenza può includere strumenti visivi che descrivono le fasi delle procedure (es. prelievo, radiografia, ECG) e meccanismi di rinforzo positivo per ogni fase completata.
Conclusione educativa
Lo shutdown rappresenta una risposta difensiva essenziale per l’individuo autistico: una tattica di auto-protezione contro stimoli ingestibili che tende a isolare e a ridurre l’impatto delle sollecitazioni. Riconoscere questo meccanismo, intervenire con empatia, prevedibilità e supporto mirato, e lavorare per una maggiore conoscenza e preparazione degli ambienti di cura e di apprendimento, permette di ridurre la frequenza e l’intensità di tali episodi e di favorire una integrazione relazionale più serena e funzionale.
Tantrum: distinguere la protesta dalla crisi
Definizione di Tantrum come Condotta di Protesta
Il termine tantrum, sebbene spesso usato genericamente, assume un significato specifico nel contesto delle condotte reattive, in particolare nei soggetti con autismo. Un tantrum è una condotta che si manifesta quando un individuo percepisce di non poter ottenere qualcosa che desidera, cerca di evitare una conseguenza negativa, o incontra difficoltà nel completare un compito o nel comunicare efficacemente. È essenzialmente una forma di protesta volta a esprimere un bisogno insoddisfatto o una frustrazione legata a un obiettivo specifico.
Questa reazione è spesso paragonata a una “lamentela” o a un “capriccio”. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che, a differenza di un capriccio inteso nel senso comune, il tantrum manca di un intento manipolativo o intenzionale nel senso di voler deliberatamente ingannare o controllare l’altro per puro piacere o potere. L’azione è piuttosto guidata dal disagio e dalla difficoltà nella gestione della situazione.
Differenze chiave rispetto al Meltdown
La distinzione più importante da fare è tra un tantrum e un meltdown. Sebbene entrambi possano presentare manifestazioni esteriori simili, come pianto, urla o scariche motorie, le loro origini e funzioni sono profondamente diverse.