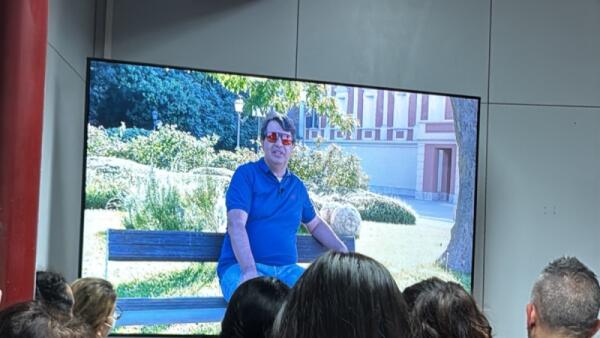Se la violenza giovanile chiama in causa scuola e famiglia
La sentenza di Napoli sulla responsabilita'della famiglia che apre nuovi scenari di responsabilità educativa anche per la scuola

La condanna di due genitori napoletani a risarcire 15mila euro per l'aggressione commessa dal figlio quindicenne segna una svolta che indirettamente parla anche al mondo della scuola che non può ignorarla. La sentenza del Tribunale civile di Napoli dello scorso 18 luglio non è solo una questione di diritto di famiglia: è un precedente che potrebbe ridefinire il perimetro di responsabilità di tutto il sistema educativo.
Fino ad ora e per decenni, la responsabilità degli insegnanti si è limitata alla culpa in vigilando: sorvegliare, impedire che gli alunni si facessero male o facessero male ad altri. Un compito chiaro, misurabile, circoscritto alle ore di lezione. Dall’altra parte la culpa in educando dei genitori, con il bizzarro scaricabarile oramai divenuto cronaca abituale.
Ma la sentenza di Napoli introduce un principio diverso: quando la violenza è "efferata" – come l'ha definita la giudice Barbara Di Tonto – diventa essa stessa la prova di un fallimento educativo. Nel caso di specie tutto da addebitare alla famiglia. Ma che la logica del diritto estende indirettamente alla scuola. Qui il tradizionale dovere di vigilanza potrebbe evolversi in dovere di prevenzione culturale a trecentosessanta gradi. Non basterebbe più contare gli alunni all'ingresso e all'uscita: occorrerebbe documentare progetti di educazione alla legalità, percorsi di gestione del conflitto, formazione specifica del personale.
Chi non sapesse esibire questa rete di anticorpi rischierebbe di trovarsi nella stessa posizione dei genitori napoletani.
La prospettiva spaventa? Forse. Ma riflette una realtà che ogni dirigente scolastico e ogni insegnante conosce bene: la scuola è diventata negli anni un perimetro di supplenza affettiva, spesso l'unico luogo in cui le storture domestiche trovano un contrappeso. Non per scelta ideologica, ma per necessità sociale.
I docenti di oggi non sono solo trasmettitori di contenuti: sono architetti di relazioni, mediatori di conflitti, sentinelle del disagio giovanile. Intercettano i segnali quotidiani che spesso sfuggono alle famiglie, gestiscono dinamiche che travalicano le materie di studio. Se la crudeltà di un ragazzino rivela il fallimento dei genitori, perché non dovrebbe svelare anche quello del corpo docente chiamato a intercettarne i segnali?
Minaccia o opportunità?
Quello che a prima vista appare come un rischio di sovra-responsabilizzazione potrebbe trasformarsi in un'opportunità. La storia ci insegna che la responsabilità, quando si allarga, produce quasi sempre virtù civiche. Dopo l'ondata di violenza giovanile degli anni Duemila, le procure minorili hanno avviato programmi di messa alla prova che hanno salvato migliaia di ragazzi.
È plausibile che la sentenza partenopea spinga scuole e famiglie a trattare la questione educativa come trattiamo la sicurezza stradale: fare prevenzione non per scacciare la sanzione, ma per disinnescare l'imprevedibile.
Se il principio dovesse consolidarsi, le scuole dovranno attrezzarsi diversamente. Gli insegnanti dovranno acquisire competenze specifiche nella gestione dei conflitti e nell'identificazione precoce dei comportamenti a rischio. Non basterà più l'improvvisazione o l'esperienza empirica, ogni intervento educativo, ogni segnale di disagio, ogni azione preventiva dovrà essere tracciata e documentata. La scuola dovrà dimostrare di aver agito con diligenza educativa.
Il coordinamento con servizi sociali, ASL, forze dell'ordine e tribunali minorili diventerà essenziale mentre la spesa per l'educazione alla legalità non sarà più un optional.
Il prezzo della libertà educativa
Resta la delicatezza di comprimere la libertà educativa. Un magistrato può giudicare un gesto, può leggere il legame tra quel gesto e l'ambiente che lo ha generato; più arduo è infilarsi nei dettagli di come si educa un ragazzo. Ma qui la magistratura non inventa nulla: ricorda che educare non è un atto di fede, bensì un dovere esigibile.
Non significa mettere sul banco degli accusati ogni insegnante al primo episodio di indisciplina. Vuol dire prendere sul serio la dimensione pubblica dell'educazione: se la violenza dei minori diventa un'emergenza sociale, lo Stato non può limitarsi alla retorica.
Una “Comunità Educante”da ricostruire
Nell'Italia che litiga per la pagella dei voti e dei programmi ministeriali, forse occorreva uno schiaffo simbolico per riportare l'attenzione sulla sostanza. Se la lezione che arriva da Napoli è che un atto brutale rende nullo ogni alibi educativo, genitori e insegnanti avranno tutto l'interesse a giocare d'anticipo, a riscoprire quella "comunità educante" di cui si favoleggia nei convegni.
Non per sfuggire a quindicimila euro di risarcimento – cifra quasi simbolica – ma per evitare che della violenza giovanile restino, domani, solo due eredi: la vittima e la colpa condivisa di chi avrebbe potuto impedirla.
La sentenza di Napoli ci restituisce la fotografia di ciò che siamo. Se oggi quella foto è sfocata, piena di ombre, di coltelli, di ragazzi arrabbiati, non è con la nostalgia che la metteremo a fuoco. Occorrerà un patto nuovo fra famiglia e scuola: meno aule improvvisate, meno fine-settimana di isolamento digitale, più cura degli spazi comuni, più dialogo intergenerazionale.
Il mondo della scuola ha davanti a sé una scelta: subire passivamente questa evoluzione giurisprudenziale o coglierla come occasione per ripensare il proprio ruolo. La responsabilità fa paura solo quando ci coglie impreparati. Se invece diventa il motore di una nuova professionalità educativa, allora la sentenza di Napoli potrà essere ricordata non come l'ennesimo allarme, ma come il punto di svolta in cui abbiamo deciso, tutti, di imparare di nuovo a educare.